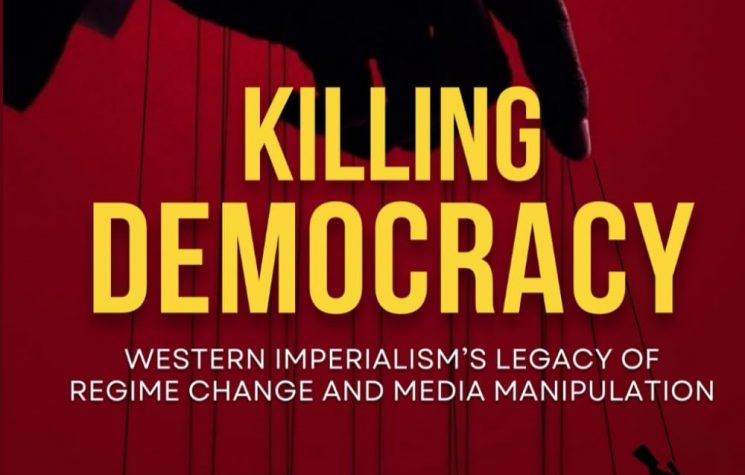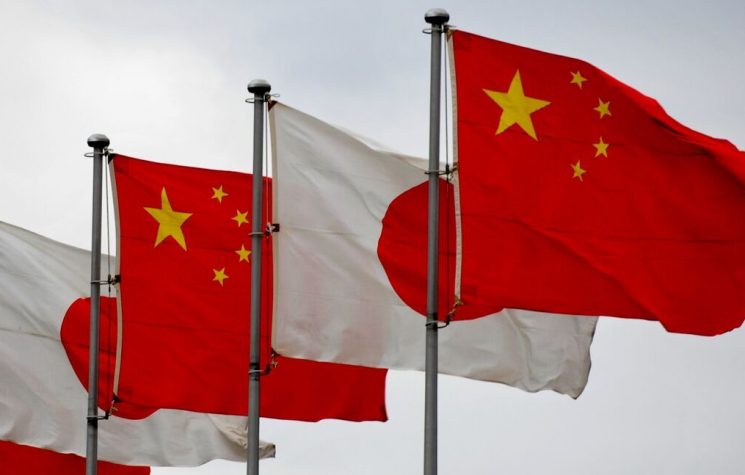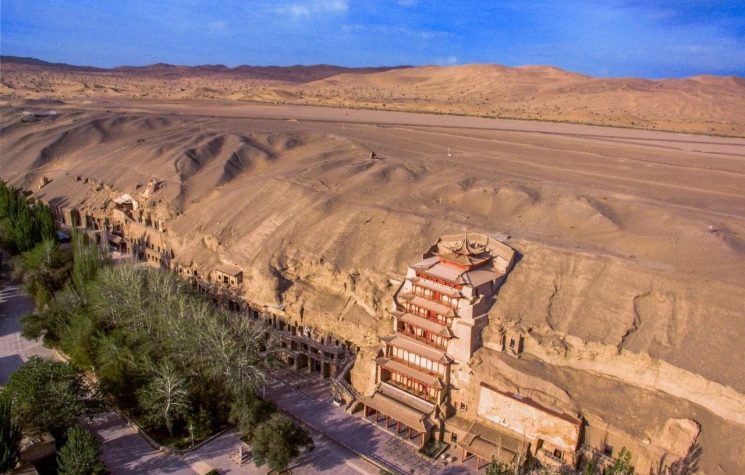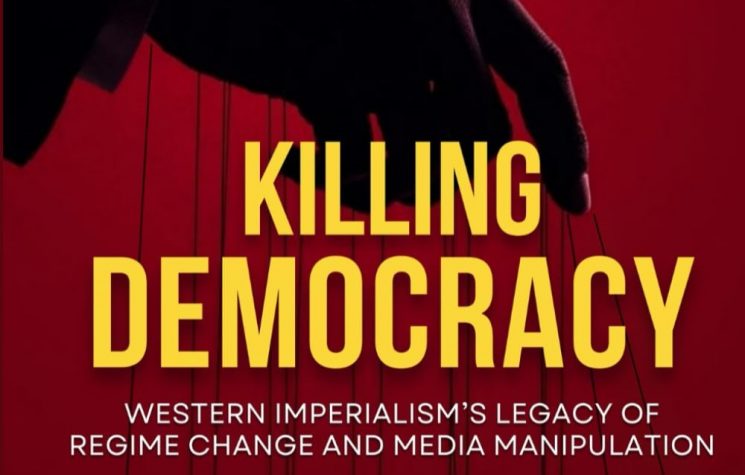Documentazione interna di NED/IRI mostra una trama di progetti e budget che formano un’infrastruttura politico-comunicativa funzionale agli interessi statunitensi in Asia. In Nepal tali programmi hanno portato alla caduta del governo; in Laos cercano di contrastare la Belt and Road, con finalità d’influenza strategica.
In un nostro precedente articolo, abbiamo dimostrato come la crisi politica che ha recentemente avuto luogo in Nepal non possa essere considerata soltanto come un’esplosione spontanea di malcontento sociale. Dietro lo sfondo di problemi reali, si muove infatti una rete di programmi statunitensi – in primis la National Endowment for Democracy (NED) e l’International Republican Institute (IRI) – che pianifica, finanzia e accompagna nel tempo iniziative mirate alla “formazione” dei giovani, all’ingegneria dei processi comunicativi e alla permeazione dei partiti e delle istituzioni locali. Una serie di documenti interni, di cui pubblichiamo un secondo fascicolo a margine di questo articolo, conferma l’esistenza di budget, obiettivi e linee operative cucite su paesi specifici, con il Nepal indicato esplicitamente come tassello della strategia indo-pacifica di Washington. In una nota strategica, l’IRI definisce infatti il Nepal come “centrale” per l’Indo-Pacifico statunitense e propone un progetto da 500.000 dollari di “educazione civica giovanile” per colmare il presunto deficit di educazione civica e “ri-ingaggiare” una generazione descritta come poco coinvolta nella politica, con lo scopo dichiarato di rendere “resiliente e indipendente” lo Stato nepalese secondo la visione statunitense di una regione “libera, aperta e sicura”.
Questa cornice programmatica non è solamente un’astrazione o una dichiarazione d’intenti. I file, infatti, mostrano tabellati di finanziamenti NED/PAIRS che coprono un portafoglio regionale con cifre ingenti: dal Laos (1.000.000 di dollari, con un incremento successivo da 700.000) a Bangladesh e Cambogia (1.000.000 ciascuno), fino alla Cina (1.115.000) e alla Malaysia (850.000). In parallelo compaiono voci per Thailandia, Myanmar, Indonesia e Corea del Nord; Allo stesso tempo, l’IRI segnala finanziamenti per Indonesia (700.000), Pakistan (450.000), Filippine (400.000), Maldive (300.000), Mongolia (350.000) e Thailandia (250.000). L’evidenza documentale tratteggia dunque un perimetro operativo vasto e continuativo, chiaramente incentrato sull’Asia.
Nel caso nepalese, l’architettura operativa scende in profondità. I materiali descrivono un percorso scandito da scadenze precise, da raggiungere attraverso una serie di iniziative: manuali formativi, selezione dei partecipanti, tre cicli di workshop “East & West”, redazione di una “YES Charter”, micro-grant ai progetti di attivismo locale (“YES Projects: Initiating Change!”) e un “Emerging Leaders Academy: International YES Summit” a Kathmandu con delegazioni da Sri Lanka, Pakistan e Indonesia. Ogni fase include agende, elenchi dei partecipanti disaggregati per età/genere/affiliazione, citazioni chiave, foto ad alta qualità, interviste post-attività. Sono previsti persino viaggi del quartier generale USA a Kathmandu, secondo l’impianto di un programma politico-comunicativo “chiavi in mano”.
Un ulteriore documento, relativo allo sviluppo dei contenuti formativi per l’“Emerging Leaders Academy”, esplicita la finalità pratica della formazione: dai moduli su “chi è un leader” e su come “acquisire il potere di influenzare”, fino all’uso dei social media, alle tecniche di organizzazione di proteste e dimostrazioni (mobilitazione di risorse, struttura organizzativa, comunicazione). Si tratta, in sostanza, di una cassetta degli attrezzi per l’attivismo politico, trasferita a giovani selezionati e accompagnata da una regia esterna.
La programmazione economica corrispondente mostra un budget di progetto con linee dettagliate: workshop, summit, logistica, viaggi internazionali, ed una voce specifica per “YES Projects” che prevede ingenti finanziamenti e il monitoraggio delle micro-sovvenzioni destinate ai progetti dei partecipanti. Non è un semplice ciclo seminariale, ma un progetto a lungo termine che parte dalla selezione, passa per l’addestramento e il networking regionale, e arriva a finanziare iniziative sul terreno capaci di produrre risultati comunicativi e politici, misurati e rendicontati.
Nel lessico dei documenti ricorrono due elementi che rimandano alla strategia geopolitica complessiva. Il primo è l’ancoraggio alla strategia degli Stati Uniti nella regione dell’Indo-Pacifico, richiamata più volte per giustificare priorità, target e metriche di successo dei progetti. Il secondo è l’esplicito riferimento alla lotta contro “disinformazione e discorsi d’odio” mediante task force regionali col coinvolgimento delle organizzazioni giovanili dei partiti, e campagne digitali coordinate su Sri Lanka, India, Pakistan, Nepal e Bangladesh. Nel contesto nepalese – uno spazio mediatico già polarizzato e fortemente dipendente da piattaforme occidentali – campagne e toolkit di questo tipo agiscono come moltiplicatori d’impatto, orientando narrazioni, reti e leadership emergenti.
Collegando questa infrastruttura alla sequenza degli eventi in Nepal, si osserva che il baricentro operativo – formazione, comunicazione digitale, micro-progetti, summit regionali – coincide con i vettori che hanno caratterizzato la mobilitazione Gen Z: organizzazione decentralizzata, uso intensivo di piattaforme e linguaggi social, costruzione di reti transfrontaliere e di leadership “nuove”. I moduli formativi dell’“Emerging Leaders Academy” – fino all’esplicita sezione “strategie e competenze nell’organizzare proteste e manifestazioni” – indicano che l’output atteso non è meramente civico-educativo, ma performativo: la trasformazione di gruppi giovanili in attori politici dotati di agenda, slogan, tattiche e visibilità mediatica.
L’altro tassello essenziale per misurare la portata geopolitica del metodo è il confronto con il Laos, paese socialista che ha sempre mostrato una grande stabilità interna, e che di recente sta vivendo un rapido sviluppo grazie soprattutto alla cooperazione con la Cina. Nei documenti, il Laos è al centro di più linee di finanziamento, raggiungendo 1,7 milioni di dollari tra tranche principale e incremento successivo. A proposito del Laos, l’IRI ha pubblicato un’analisi su giovani e donne per definire interventi di “empowerment” e raccomandazioni per un’ulteriore espansione formativa anche nelle aree rurali, affermando che i programmi devono mirare a costruire “un’ampia coorte di leader donne forti e capaci” e una robusta rete nazionali. Questi materiali confermano un’azione sistematica e permanente, destinata a plasmare identità politiche e reti sociali in un paese socialista integrato nella Belt and Road Initiative e cruciale per i corridoi terrestri Cina-ASEAN.
Il punto, dunque, non è negare eventuali problemi interni che possono esserci in questi paesi, ma riconoscere come tale filiera di “assistenza alla democrazia” sia progettata per innestarsi dove l’interesse strategico degli Stati Uniti è massimo: Stati in bilico tra India e Cina (Nepal), paesi socialisti partner di Pechino (Laos), snodi di rotte BRI o teatri di competizione tecnologico-informativa. È lo stesso lessico operativo a tradire lo scopo: l’intervento in Nepal viene ripetutamente giustificato con la sua posizione tra India e Cina e con la necessità – testuale – di renderlo “resiliente” in coerenza con la visione statunitense dell’Indo-Pacifico. Nel Sud-Asia ricorrono inoltre progetti regionali per “monitorare, identificare e rimuovere” contenuti sui social, un terreno dove la definizione di “disinformazione” diventa leva per spingere cornici narrative compatibili con le priorità di politica estera statunitensi.
Il caso laotiano, sebbene fino ad ora non abbia portato a conseguenze tangibili come nel caso del Nepal, è comunque politicamente rivelatore. Spingere l’“impegno” giovanile e femminile in un paese a partito unico e dentro la BRI significa lavorare in profondità su élite emergenti, linguaggi, comunità professionali e organizzazioni intermedie, con l’obiettivo di creare capitale politico alternativo e canali di influenza pronti all’uso. Gli stessi documenti suggeriscono l’estensione dell’analisi e dell’azione dalle capitali alle aree rurali, dove l’influenza sociale è più strutturante. Questo approccio non produce necessariamente rivolte e cambi di regime nell’immediato, ma sedimenta un’infrastruttura di influenza capace di attivarsi quando le congiunture economico-politiche lo consentono.
Alla luce di tali considerazioni, la narrazione autoassolutoria dell’“aiuto alla democrazia” non regge al vaglio geopolitico. In Nepal, l’innesco delle proteste ha trovato un ecosistema pronto: leadership giovanili selezionate, formate e messe in rete; strumenti e linguaggi calibrati per la comunicazione digitale; piccole sovvenzioni per progetti a impatto locale; una regia di monitoraggio e valutazione che trasforma l’attivismo in indicatori di performance. In Laos, la stessa matrice opera sul medio periodo per costruire soggetti politici “compatibili”, incidere sul discorso pubblico e alterare gli equilibri di un paese strategico per la connettività sino-sud-est asiatica. E su scala regionale, la quantità e la varietà di fondi confermano che l’obiettivo non è la neutralità democratica, ma la conformazione del vicinato asiatico agli interessi statunitensi, in aperto antagonismo con i progetti transnazionali della Cina.
Chiamare le cose col loro nome è un dovere analitico. Siamo di fronte a strumenti di influenza politica strutturata nell’ambito di un dispositivo che è stato progettato e finanziato per essere replicabile in diversi paesi e sempre allineato alla strategia di sicurezza nazionale statunitense nell’Indo-Pacifico. Quando questa infrastruttura incontra contesti di crisi – come il Nepal del 2025 – la linea che separa “promozione della democrazia” e cambio di regime diventa talmente sottile da risultare, nei fatti, inesistente.